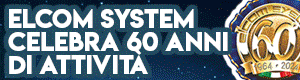Eravamo ragazzi anche noi, all’epoca.
Un paio d’anni dopo avremmo avuto anche noi un cellulare. Sarebbe stato di quelli pesanti, che non entrano in tasca, con l’antenna da tirare fuori per poter parlare e il costo di ogni telefonata un salasso. Se avessimo avuto gli smartphone di oggi li avremmo usati come li usano tutti i ragazzi di adesso. Allora anche io avrei fotografato i quadri, gli affreschi, le sculture di Nino Cordio. Le avrei postate sui social, insieme a una foto di me con loro, con Nino, Graziella, i loro figli Rossella e Francesco, il mio fidanzato che me li aveva fatti conoscere, tutti un po’ abbracciati accanto ad una delle opere di Nino. Mi sarebbe piaciuto far sapere in giro che lì, tra le opere e i materiali con cui venivano create, c’era un senso di famiglia che accoglieva anche noi. Ci accoglieva certi sabati di primavera, tra i profumi di cera, di bronzo, di colori o di calce degli affreschi, di cucina buona, di fiori, di lenzuola pulite, di casa.
Non l’ho potuta postare quella foto di me e il mio fidanzato “adottati” dai Cordio, come spesso ci siamo sentiti, perché tra una cosa e l’altra non ci è venuto in mente di scattarla. In quell’epoca di cellulari pesanti come mattoni non si usava scattare foto di ogni cosa. E poi in quei fine settimana trascorsi da loro in campagna era difficile distrarsi quando Nino parlava, quando ci parlava.
Parlare coi ragazzi doveva essere una delle cose che più gli piaceva fare, sarà stato anche perché aveva lavorato come insegnante. Era praticamente impossibile ascoltare un suo discorso che non avesse almeno un contenuto fondamentale. Era impossibile, per me e il mio fidanzato, tornare a casa senza aver ricevuto in dono un’idea, un pensiero, una soluzione ai nostri dilemmi giovanili, a una scelta di studio, di vita, di unione. Ma tutto questo accadeva senza che Nino la facesse cadere dall’alto, senza quell’aria di chi deve per forza insegnare qualcosa, magari con l’enfasi di un capo famiglia o un maestro, di uno che ha la verità con sé. Tutto accadeva e basta. Nino ci dava lo spunto, l’idea, la soluzione, il coraggio di osare, e lo faceva sempre in modo delicato, tra un piatto di formaggi e un bicchiere di vino, una stanza un po’ in disordine e… quella luce.
Era la luce ciò che noi ragazzi, io e il mio fidanzato riportavamo a casa, a bordo di una A112 sgangherata, tra le curve dissestate di quell’Umbria selvaggia, l’Umbria di Nino, il luogo del suo terzo tempo dopo quello della Sicilia e di Roma. La luce che lui faceva sua, che ci insegnava a cogliere, magari con qualche accenno di tecnica su come usarla, era una luce che andava oltre. Era nelle parole, nello sguardo, nella sua immensa volontà di lasciare un dono ai suoi figli e a noi, che non studiavamo arte figurativa ma studiavamo pur sempre qualcosa, il mio ragazzo all’Accademia d’Arte Drammatica insieme a Francesco, io al Centro Sperimentale di Cinematografia. Quella luce era per tutti noi e per gli allievi di Nino di un tempo, per gli scrittori e chiunque tenesse all’importanza della parola e di un punto di vista personale sul mondo, per gli amici che passavano per quella casa anche solo per un saluto. Quella luce arrivava sempre e restava nostra.
Eravamo finiti a casa loro la prima volta pensando ad un teatro da costruire lì davanti, in quella campagna tra Todi e Collelungo dove i primi telefoni non avevano campo e nessuno se ne faceva un problema. Accanto a quello spiazzo pensato per il teatro c’era lo studio di Nino, e dentro lo studio c’erano le sue opere in crescita continua, c’erano l’esplorazione e il divertimento, la passione e il lavoro duro, le mattine all’alba, il freddo dell’inverno umbro. Tra le pareti fatte di enormi finestre, c’era la scelta che Nino aveva fatto di andare via da Roma e farsi raggiungere dai figli ormai grandi e da Graziella durante la settimana, ogni volta che fosse possibile. Quel loro viaggiare frequente per poter stare tutti insieme era la loro collaborazione alle opere di lui. Ho sempre pensato che in questo luogo, questa casa dalla porta sempre aperta, fossero sparse ovunque come delle firme di gratitudine familiare. Il grande affresco che occupa tutte le pareti all’ingresso della casa, con ritratti loro quattro, a me sembrava proprio raccontare la gratitudine di Nino a loro e di loro a lui. La stessa che qualche volta trapelava da una battuta ironica che Nino rivolgeva a uno dei figli o alla sua elegante e intelligente moglie, che un tempo era stata sua allieva. Le rivolgeva magari un gesto affettuoso e mai smielato, nessuna leziosità, tra loro tanta riconoscenza reciproca.
Quei fine settimana, per noi ragazzi, segnavano sempre qualcosa.
I pranzi avvenivano nella sala che era proprio di quelle di una volta, costruite in modo che ci fosse posto per tutti. Da una parte c’era il tavolo per mangiare e dall’altra un altro tavolo con una parte di certi lavori, sculture di bronzo, di cera e di legno, una in particolare che ricordo di Rossella bambina seduta con le mani sulle ginocchia, una posa timida, in ascolto. Quei pranzi diventavano giorni, diventavano viaggio. C’erano i discorsi sulla politica del momento, sullo spreco del tempo che noi ragazzi non dovevamo avallare, sui progetti futuri in cui dovevamo credere ma senza forzare la mano, senza prendersi troppo sul serio, senza dimenticare l’ironia e la semplicità. Poi tralasciavano la politica e diventavano discorsi sui colori del cielo in quelle mattine all’alba, o nelle sere al crepuscolo, sui colori degli alberi e dei frutti di stagione, sul cibo cucinato a casa.
Mi ricordo tra le innumerevoli opere di Nino che mi capitò davanti durante una delle sue mostre a Todi, c’era un dipinto che ritraeva un uovo sodo in un piatto, diviso in due parti perfette, gialle e il bianche, il condimento appena visibile, la luce di un giorno caldo. Nino mi disse che quel semplice soggetto raccontava l’attesa del pranzo di una coppia, forse una coppia di poveri, contenti secondo lui di avere quella piccola cosa da condividere. Forse ripensava ai suoi nonni contadini in Sicilia. In quel dipinto c’era una storia, e raccontava la semplicità della condivisione.
Se potessi riassumere ciò che secondo me l’artista Nino Cordio, maestro, padre di due cari amici, signore gentile, ci ha regalato, a me viene in mente il soggetto di quel quadro, l’uovo sodo diviso in due, e quella cosa importante, la semplicità della condivisione. Gli sarò sempre grata per il fatto che andarsene dalla sua casa, dal suo studio, dalla sua famiglia, era sempre un po’ difficile. Grata per il fatto che non ci è mai mancato l’uso di uno smartphone mentre lui ci parlava. Grata per quella semplicità con cui raccontava la bellezza del mondo.
E per quella luce.